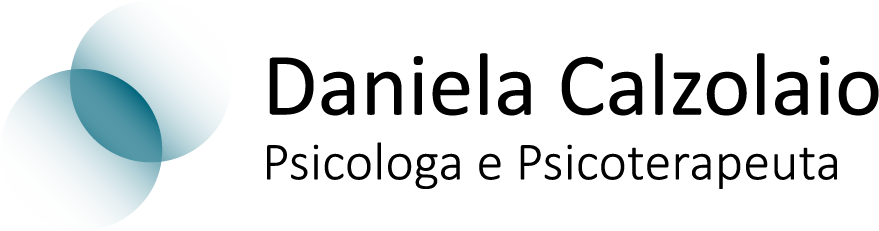Sul perché penso che dovremmo evitare abusi e usi “leggeri” di categorie e definizioni di noi e degli altri.
Introduzione
Possiamo pensare che ogni persona abbia i suoi modi tipici e preferenziali di percepire, “sentire”, relazionarsi, comunicare, comportarsi, fare esperienza delle cose e darvi significato. Ognuno ha anche la sua rete di valori, di premesse, di convinzioni: qualcosa che ci guida, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ciascuno di noi, però, certamente sa anche, per esempio, che il modo in cui interagisce con sua madre non è lo stesso di quello in cui lo fa con sua sorella, con un collega, con l’attuale partner, e che questi modi probabilmente non sono gli stessi di quelli che ha usato in passato con le stesse persone: tutti ci comportiamo e siamo in modi che in una certa misura mutano in dipendenza da tanti fattori, inclusi il contesto in cui ci troviamo, il ruolo che di volta in volta ricopriamo, il momento di vita che stiamo attraversando, la persona che abbiamo di fronte, la storia della nostra relazione con lei, il modo in cui percepiamo che lei ci veda. Tutto questo bene o male lo sappiamo, se ci fermiamo un attimo a pensarci (anche se forse lo abbiamo in mente più quando riguarda noi stessi e meno quando riguarda gli altri). In tutta questa variabilità, manteniamo ovviamente, di norma, una nostra “coerenza interna”, cioè non ci “trasformiamo” in persone diverse: siamo sempre noi, con i nostri modi “preferenziali” e caratteristici di essere e di fare, ma questi sono connotati da un certo grado di mutevolezza, di interdipendenza col mondo esterno, di complessità.
Le impreviste conseguenze del definire
Da tutto questo discende un fatto che riguarda ciò che accade quando usiamo parole per definire noi stessi e gli altri. Può trattarsi di aggettivi con cui descriviamo, di categorie in cui inseriamo, di vere e proprie diagnosi (o pseudo-diagnosi) che attribuiamo: “Tizio è un invidioso”, “Caia è una che fa la vittima”, “Sempronia è depressa”, “Procopio è un narcisista”, “Genoveffa è una persona tossica”. E il fatto è che, quando noi usiamo parole per definire noi stessi e gli altri, corriamo vari rischi. Il primo, ovviamente, è quello di commettere errori di valutazione; ad esso ne è connesso un altro: è quello di dimenticarci che la nostra definizione dell’altro rispecchia una valutazione che è sempre una valutazione da un punto di vista e non una verità assoluta. Ma ci sono altri rischi che sono meno appariscenti di questi: quando noi usiamo parole per definire noi stessi e gli altri stiamo inevitabilmente fissando ciò che è invece mutevole, stiamo fermando ciò che è invece mobile, stiamo riducendo una vastissima complessità a ciò che è contenuto in una parola la quale, ancora inevitabilmente, non può che essere parziale e cogliere solo uno o pochi aspetti della realtà. Ma anche questo non è propriamente vero: una parola tocca uno o pochi aspetti di ciò che noi abbiamo visto della realtà o, ancora meglio, di ciò che noi abbiamo colto di quanto è emerso dalla nostra interazione con quel pezzo di mondo che stiamo osservando e poi definendo.
Certamente non possiamo evitare di definire noi stessi e gli altri con singole parole precise: ci facciamo un’idea delle cose e la “mettiamo in parole”, e pensare di dovere ogni volta esplicitare tale idea con un articolato e sterminato discorso sarebbe assurdo. Di più. Non possiamo evitare, in generale, di categorizzare e definire, come ho più approfonditamente scritto qui.
E allora c’è un aspetto che è importante – io credo: non dovremmo perdere di vista il fatto che la complessità delle cose resta anche se una definizione non può coglierla, e dovremmo evitare – come ho scritto all’inizio – abusi e usi “leggeri” di categorie e definizioni. Quando noi diciamo “Tizio è un invidioso”, “Caia è una che fa la vittima”, “Sempronia è depressa”, “Procopio è un narcisista”, “Genoveffa è una persona tossica”, dovremmo avere bene in mente che stiamo correndo il rischio di identificare Tizio, Caia, Sempronia, Procopio e Genoveffa con le parole che stiamo usando per descriverli, cioè di far coincidere la persona con l’etichetta che le abbiamo attribuito. E’ un po’ quello che accadrebbe se scambiassimo una fotografia per ciò che è stato fotografato, se ci dimenticassimo che la fotografia “è ferma” mentre ciò che è stato fotografato è un divenire, che la prima non può cogliere tutto ciò che è il secondo, che essa può esaltare aspetti che il secondo forse anche contiene ma che certo non lo esauriscono.
Non solo: io scatto una fotografia in certe condizioni di luce, da una certa prospettiva, guidata da ciò che so sul fare foto, forse usando certi filtri, seguendo le mie preferenze di scatto e magari anche le tendenze del momento nel mondo della fotografia. Con le definizioni accade qualcosa di simile: definisco l’altro in base ai miei filtri (le mie premesse, le mie convinzioni, i miei valori, e così via), dal mio punto di vista (ciò che ho osservato io, da dove sono, per come sono), eccetera eccetera. E – io credo – anche “pescando” tra le categorie e definizioni “disponibili”: nel nostro modo di pensare, nella nostra famiglia, nei nostri gruppi di riferimento, nella nostra comunità, nella più ampia società e nel tempo in cui viviamo certe categorie e definizioni possono essere più presenti e radicate di altre. Se, per esempio, per una persona o una famiglia sono significativi valori o attributi come la giustizia o la bontà o la scaltrezza (e i loro opposti), allora potremmo aspettarci in esse una tendenza a cogliere nella “realtà” aspetti coerenti con essi e a significare e valutare se stessi e il mondo esterno in un modo altrettanto coerente.
Ci sono anche – dicevo poco fa – categorie e definizioni particolarmente “di tendenza” in una certa società in un certo periodo di tempo. Se non ci credete, pensate alle streghe, esistenti nel pensiero e nel linguaggio di tutto sommato pochi secoli fa. E il fatto che esse esistessero “solo” nel pensiero e nel linguaggio non ha impedito, purtroppo, effetti molto concreti e reali per le persone che dentro a tale categoria malauguratamente venivano infilate. Questo ovviamente è un esempio estremo, ma se ci pensiamo anche la nostra società attuale ha i suoi “tipi” da andare a cercare in giro. Meno fantasiosi delle streghe, ma comunque degni di menzione. Nell’articolo Sullo strano caso della diffusione del “narcisismo” faccio un esempio di quanto sto cercando di dire.
Conclusioni
Il modo in cui definiamo noi stessi e gli altri e le categorie cui ricorriamo non sono privi di conseguenze. Si può arrivare addirittura a discriminare certe persone solo perché le abbiamo messe, a volte frettolosamente o per pura comodità, dentro a una certa categoria: pensiamo a quante volte capita di leggere, per esempio, consigli su come allontanare da noi certe “tipologie” di individui, come le non ben specificate “persone negative” o “i vittimisti”!
Ma quello che ho detto ha un effetto – se ci pensate – non solo sul modo in cui valutiamo, definiamo e vediamo l’altro: ha un effetto anche sul modo in cui valutiamo, definiamo e vediamo noi stessi, e dovremmo chiederci se e quali effetti abbia percepirsi (come mi capita sempre più spesso di vedere), per esempio, come una “vittima caduta nella trappola di un narcisista maligno”, come la marionetta manovrata dal “manipolatore” che ne tiene i lacci o come il malcapitato “avvelenato” da una “persona tossica”. E dovremmo anche chiederci – io credo – se e quali effetti tutto questo abbia su noi-nella-relazione e sulla relazione stessa: quando tutto si schiaccia in una definizione dell’altro e/o di noi stessi, in un rapido incasellamento in una data classe, si rischia di rendere ancora più ardua la possibilità di scorgere le modalità comunicative e di interazione che tale relazione caratterizzano, alle quali noi stessi partecipiamo e che magari contribuiscono al manifestarsi di dinamiche disfunzionali.
Articoli correlati
Maggio 27, 2023